maurizio valdarnini
tribute to 163rd Signal Photo Co.
«[...] l'euforia manifestata da alcuni autori per la trasformazione digitale della fotografia si spiegherebbe proprio con il recupero di un forte principio di codificazione rispetto allo statuto della fotografia analogica»
Claudio Marra*
All’origine di tutto c’è l’incontro, folgorante, con le immagini di
Walter Rosenblum, il grande fotografo statunitense che durante la seconda Guerra Mondiale operò nel reparto di documentazione dell’US Army. Immagini nate per documentare la guerra, non per… denunciarne gli orrori, come avviene oggi in modo non di rado autocelebrativo. Quelle di Rosenblum sono infatti immagini potenti, vissute, che scatenano un’ammirazione sincera non solo per il valore dei singoli scatti, ma anche per il lavoro coscienzioso e certo non privi di pericoli che non tutti i fotografi arruolati svolsero durante il conflitto.
Ecco nascere quindi l’idea dell’omaggio a fotografi quasi mai celebrati e spesso dimenticati. Dall’ammirazione all’identificazione il passo è spesso breve, ma da quest’ultima alla realizzazione di un lavoro complesso e articolato la distanza è molto più lunga. Per ogni singolo scatto ci sono voluti fino a sei mesi di lavoro minuzioso, maniacale, appassionato. A metà strada tra modellismo e scenografia nascono quindi gli sfondi di un mondo sconvolto dal conflitto. Non resta che inserire i fotografi-soldati. È lo stesso autore a impersonarli, «mettendoci letteralmente la faccia», come lui stesso afferma. In mano apparecchi d’epoca posti in giusto risalto dall’illuminazione. Pose dinamiche, statiche, a cui si aggiunge talvolta l’introduzione di un mosso che rimanda a pericolose manovre sotto il tiro dei proiettili nemici. È uno sforzo di realismo estremo, sconfessato contemporaneamente dallo sfocato che denuncia le dimensioni da plastico delle ambientazioni.
Inquadrata la genesi del lavoro – passaggio inevitabile e fondante dei successivi ragionamenti – rimangono gli interrogativi posti dal progetto nel suo complesso. Al di là infatti dei richiami concettuali e formali a Yasumasa Morimura e Paolo Ventura, le cui motivazioni sono in entrambi i casi evidentemente indirizzate altrove, è il ruolo stesso dell’immagine fotografica a essere messo in discussione.
Che la fotografia sia in grado di mentire è un assunto che si spera assodato e accettato. Di fatto, il complesso atto fotografico compiuto dall’autore mira a ingannare lo spettatore con artifici finalizzati a rendere verosimile l’impianto scenico, che però
vero non può essere. Non fosse altro per diritto d’anagrafe. L’autore è infatti nato all’inizio degli anni Sessanta, quasi venti anni dopo la fine del conflitto, e sebbene sia fotografo non ha mai militato nell’esercito americano. Si apre quindi un interessante spiraglio sul concetto di memoria e sulla sua trasmissibilità attraverso la fotografia. Quella che si esprime in queste immagini non può certo essere una memoria autobiografica. Semmai è il frutto di una memoria semantica (per continuare a utilizzare le definizioni Tulving), acquisita in funzione degli interessi personali, ma anche dei racconti ascoltati durante infanzia e adolescenza e poi arricchiti e completati dallo studio. Quest’ultima finisce, di fatto, per fondersi con la prima divenendone parte in un unicum che poi trova forma nell’immagine fotografica.
Cosa ci racconta dunque questo lavoro sulla natura del
medium?
Posto che, ovviamente, non siamo all’interno del genere fotogiornalistico e quindi non c’è pretesa di verità, bensì di encomiastico omaggio ai fotografi-soldato della Seconda Guerra Mondiale, la relazione di causalità tra referente e rappresentazione si articola su una dimensione temporale. Se è vero che tanto l’autore-soggetto quanto l’ambientazione si sono trovati in un certo istante davanti all’obiettivo, è altrettanto vero che ciò è accaduto in momenti differenti, e solo successivamente è avvenuto il ricongiungimento tra le due parti. Il verosimile risultato che ne scaturisce manda quindi in crisi le basi della teoria del messaggio in assenza di codice. È infatti l’intervento digitale che, unificando i differenti momenti del tempo (ma anche dello spazio) genera la codifica, superando il
sistema indicalea favore di un sistema iconico. In altre parole, se ci riferiamo alla distinzione che Barthes oppone tra fotografia e disegno, paradossalmente queste immagini sarebbero più vicine a quest’ultimo che non a un messaggio di tipo continuo.
[ Sandro Iovine ]
--------------------------------------------
(*) - Claudio Marra, L'immagine infedele, la falsa rivoluzione della fotografia digitale, Bruno Mondadori, Milano, 2006; pag. 78.
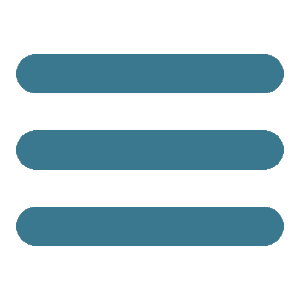
 home
cover ▼
opinioni
FPart
notizie ▼
smartfolio
portfolio
post.it
post.cast
video
ongoing
percorsitematici
googlecards
FPtag
home
cover ▼
opinioni
FPart
notizie ▼
smartfolio
portfolio
post.it
post.cast
video
ongoing
percorsitematici
googlecards
FPtag










 Maurizio Valdarnini - Nato a Roma, Valdarnini si è diplomato all'Istituto Europeo di Design, iniziando in seguito a lavorare prevalentemente nella capitale come fotografo ritrattista e collaborando con alcune delle più importanti agenzie di pubblicità e magazine italiani. Laureato in Sociologia, è docente da quasi trent'anni presso l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma (
Maurizio Valdarnini - Nato a Roma, Valdarnini si è diplomato all'Istituto Europeo di Design, iniziando in seguito a lavorare prevalentemente nella capitale come fotografo ritrattista e collaborando con alcune delle più importanti agenzie di pubblicità e magazine italiani. Laureato in Sociologia, è docente da quasi trent'anni presso l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma (